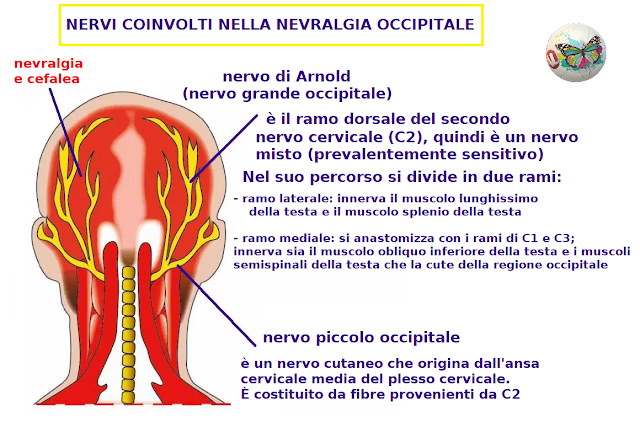Palmitoiletanolamide (PEA): recenti acquisizioni in Terapia del Dolore - Dott. Giorgio Mariot
Nel trattamento del dolore neuropatico gli oppiacei hanno un ruolo
marginale, risultando efficaci solo in certe condizioni come il dolore
periferico[1], dove potrebbero risultare implicati i nocicettori dei
nervi nervorum[2].
Fra i farmaci indicati di prima linea ci sono la duloxetina ed il pregabalin; quest’ultimo, se somministrato in associazione alla duloxetina risulta efficace a minore dosaggio e con meno effetti collaterali[3,4].
Anche i farmaci cannabinoidi sono risultati efficaci nella cura del dolore neuropatico, come riportato in una recente rassegna[5].
Mentre conosciamo l’azione della duloxetina sul potenziamento delle vie inibitorie discendenti del dolore, meccanismo ritrovato anche nei cannabinoidi[5,6] e pare anche nel pregabalin[7], non sono note le similitudini o le differenze fra pregabalin e cannabinoidi.
La glia ha un’importante azione sulla genesi del dolore neuropatico, e farmaci particolarmente efficaci sul dolore neuropatico potrebbero avere un’azione di interferenza sulla glia.
Se i cannabinoidi e la PEA (endocannabinoide) hanno similitudini nel meccanismo d’azione del pregabalin, allora potrebbe essere possibile sostituire quest’ultimo farmaco con la PEA, ottenendo l”a scomparsa dei noti effetti collaterali.
Sistema endocannabinoide
Il corpo umano possiede specifici siti di legame per i cannabinoidi sulla superficie di molti tipi cellulari e l’organismo produce diversi endocannabinoidi derivati degli acidi grassi, che si legano ai recettori cannabinoidi (CB), attivandoli. I recettori CB e gli endocannabinoidi costituiscono il sistema cannabinoide endogeno.
Sono stati identificati due tipi di recettore per i cannabinoidi, chiamati CB1 e CB2.
I recettori CB1 si trovano principalmente nell’encefalo, in particolare nei gangli della base, nel globus pallidus e nella substantia nigra e, in misura minore, nel cervelletto, nell’ippocampo, nel nucleo caudato, nel putamen, nell’ipotalamo e nell’amigdala. Sono stati inoltre individuati, ma con minore densità, anche nei polmoni, nel fegato, nei reni e nelle cellule dell’apparato riproduttivo sia maschile che femminile. I recettori CB1 sono invece assenti nel midollo allungato, la parte del sistema nervoso che presiede al controllo delle funzioni respiratorie e cardiovascolari.
Il legame dei cannabinoidi ai recettori CB1 causa una inibizione presinaptica del rilascio di vari neurotrasmettitori (in particolare dopamina e glutammato), ed una stimolazione delle aree della sostanza grigia periacqueduttale (PAG) e del midollo rostrale ventromediale (RVM), che a loro volta inibiscono le vie nervose ascendenti del dolore. A livello del midollo spinale il legame dei cannabinoidi ai recettori CB1 causa una inibizione delle fibre afferenti a livello del corno dorsale.
La stimolazione dei recettori CB1 è responsabile degli effetti euforizzanti dei cannabinoidi, ma anche della loro azione antiemetica, antiossidante, ipotensiva, immunosoppressiva, antinfiammatoria, analgesica, antispastica e stimolante dell’appetito.
Per quanto riguarda i recettori CB2 si è a lungo ritenuto che si trovassero quasi esclusivamente sulle cellule T del sistema immunitario, con la più alta densità a livello della milza; un recente studio ha invece mostrato la loro presenza anche a livello del sistema nervoso centrale[8].” La stimolazione dei recettori CB2 sembra essere responsabile principalmente dell’azione antinfiammatoria e immunomodulatrice dei cannabinoidi.” Ma non è chiarito finora quale dei due recettori o se entrambi siano responsabili dell’azione analgesica esercitata dai cannabinoidi.
Considerata l’efficacia sul dolore neuropatico, è ipotizzabile che l’azione dei cannabinoidi possa essere ricondotta ad un effetto di modulazione della glia operato dai recettori CB2, piuttosto che un’azione analgesica propria, ottenuta dall’attivazione dai recettori CB1.
Se questa ipotesi fosse corretta, si potrebbe ottenere analgesia evitando gli effetti psicotropi evidenziati dai fitocannabinoidi.
Nella fig. 1 sono rappresentati i principali endocannabinoidi, i più importanti fitocannabinoidi e la palmitoiletanolamide (PEA), un endocannabinoide di sintesi.
La PEA è una molecola strutturalmente simile all’endocannabinoide anandamide (AEA) ma, a differenza di quest’ultima, non interagisce con i recettori CB1. La PEA è inoltre in grado di ridurre il rilascio di istamina e di fattori proinfiammatori dai mastociti[9,10].
Plasticità neuronale
La glia è implicata nella percezione ed elaborazione del dolore: attivata dall’infiammazione neurogena, secondaria alla stimolazione nocicettiva, agisce dinamicamente regolando la comunicazione sinaptica neuronale e può incidere sulla via del dolore patologico con il rilascio di neurotrasmettitori, neuromodulatori, citochine proinfiammatorie e chemochine[11]. L’infiammazione, importante meccanismo di difesa, causa anche degenerazione neuronale e sinaptica, ed i residui causati dall’evento lesivo infiammatorio, vengono prontamente eliminati dall’attività macrofagica microgliale per permettere la ricostruzione delle nuove vie sensitive. Questo processo distruttivo/ripartivo è alla base della plasticità neuronale, che in alcuni casi porta alla plasticità maladattativa. La percezione del dolore non si limita a coinvolgere un’analisi momento per momento dell’ingresso nocivo afferente, bensì comporta un processo dinamico che è influenzato dagli effetti delle esperienze passate. Stimoli sensoriali agiscono sui sistemi neurali che sono stati modificati dagli imputs del passato, ed il risultato comportamentale è significativamente influenzato dalla “memoria” di questi eventi precedenti[12,13,14].
Questo fenomeno è anche alla base del concetto di territorio neuroanatomicamente plausibile di Treede[15] in cui la persistenza del dolore causa un’espansione oltre la zona di competenza sensitiva del nervo implicato, come si evidenzia nella sindrome del tunnel carpale o come si può notare in certe coxalgie che presentano un dolore riferito ben oltre il ginocchio, a volte fino alla caviglia, nei pazienti che in passato hanno sperimentato delle lombosciatalgie, od ancora in certi dolori stenocardici che si ripetono sempre nella sede del primo attacco, indipendentemente dal ramo coronarico implicato.
Quando un neurone rilascia glutammato, questo si lega anche ai recettori degli astrociti contigui e si genera un’onda di calcio che si propaga raggiungendo gli astrociti più lontani. L’onda si genera per il formarsi di un gradiente di calcio fra reticolo endoplasmatico e citoplasma, innescato dall’inositolo trifosfato.
La sinapsi elettrica, a differenza della sinapsi chimica, permette la comunicazione tra due cellule eccitabili mediante il passaggio diretto di corrente elettrica. Una caratteristica importante che contraddistingue questo tipo di sinapsi è il verificarsi della trasmissione senza il caratteristico ritardo sinaptico che contraddistingue la trasmissione chimica ed utilizza canali ionici che offrono bassa resistenza alle correnti.
Questi canali vengono definiti gap junctions, e sono morfologicamente formati da particelle intermembranarie costituite da 6 subunità proteiche (connessine) disposte a formare un connessone.
In questo modo il sistema astrocitario, più veloce nella trasmissione dell’informazione, riesce a m”odulare la comunicazione fra neuroni.
Pregabalin e PEA
Il pregabalin risulta efficace nel dolore neuropatico perché blocca la subunità α2δ dei canali del calcio di tipo n[7]. Questi canali, come altri recettori, sono iperespressi nel dolore neuropatico e l’efficacia del farmaco dipende dalla varietà genetica delle subunità coinvolte[16,17,18].
Quando l’impulso nervoso arriva al bottone sinaptico, trasportato dalla differenza di potenziale provocata dallo scambio Na+—K+, vengono attivati i canali del calcio di tipo n che permettono l’ingresso di Ca++ in scambio con K+. E’ il Ca++ intracellulare che causa la degranulazione delle vescicole contenenti i neurotrasmettitori e la conseguente trasmissione sinaptica.
Il pregabalin, inibendo l’ingresso di calcio, impedisce l’uscita dei neurotrasmettitori come il glutammato, la sostanza P ed altri, impedendo l’attivazione degli astrociti[19,20].
Per quanto riguarda i cannabinoidi, l’azione è un po’ diversa: il glutammato rilasciato dal terminale presinaptico si lega ai recettori post-sinaptici ed agli astrociti attivando le interazioni fra astrociti e fra gli astrociti ed i neuroni, mentre la membrana post-sinaptica sintetizza endocannabinoidi che a feed-back inibiscono il rilascio di glutammato bloccando l’attività astrocitaria[24,25].
Mentre molti fitocannabinoidi e gli endocannabinoidi, oltre ad attivare i CB2, possiedono un’azione analgesica diretta, agendo sui recettori CB1 situati sulla membrana presinaptica, la PEA è priva di questo effetto, mentre interagisce con gli astrociti (dotati di recettori CB2) desensibilizzando i circuiti neuronali[8,9,10].
Clinicamente è possibile notarne la differenza: mentre i fitocannabinoidi provocano analgesia appena somministrati, gli effetti della PEA si evidenziano dopo 20-30 giorni dall’inizio del trattamento.
E’ logico pensare che possa esserci un sinergismo fra pregabalin e cannabinoidi.
Nel lavoro dei coniugi Luszczki venirono testate le reazioni dei topi alla piastra calda dopo somministrazione intraperitoneale di pregabalin, WIN 55,212-2 mesylate (cannabinoide sintetico) e pregabalin, dimostrando sinergia nell’associazione farmacologica[21].
In realtà i tests furono eseguiti con dosi molto alte di pregabalin (75 mg/kg) e dosi equivalenti (calcolate sull’effetto antinocicettivo) di cannabinoide, e venne valutata la risposta sul dolore nocicettivo e non su un modello di dolore neuropatico.
Il dubbio che ne deriva è che sia stato misurato non il grado di analgesia, ma il livello di sedazione ottenuto, sicuramente elevato.
Il dubbio sarebbe confermato dalle osservazioni cliniche, dove il pregabalin si comporterebbe come inibitorie dei cannabinoidi sia per quanto riguarda gli effetti mediati dai recettori CB1 che dai CB2.
Un paziente in trattamento con pregabalin 75 mg bid per un dolore neuropatico post-operatorio, cultore occasionare dell’uso ricreativo della cannabis, riferiva assenza totale degli effetti psicotropi dopo aver assunto fitocannabinoidi.
Altri pazienti in trattamento con pregabalin con scarsi risultati per sindrome fibromialgica, venirono ruotati a PEA. In quelli che dimenticarono di sospendere il pregabalin non ci fu miglioramento clinico, cosa invece evidenziata nei pazienti più diligenti. Il miglioramento si evidenziò peraltro alcuni giorni dopo la sospensione del pregabalin.
Ancora, per quanto riguarda le interazioni farmacologiche, il blocco dei recettori NMDA impedisce (in vitro) l’azione del pregabalin sulla degranulazione delle vescicole presinaptiche[22].
Una possibile spiegazione al fenomeno dell’inibizione dell’azione cannabinoide da parte del pregabalin potrebbe essere dedotta dalla presenza di alcuni leganti sintetici che hanno dimostrato un effetto agonista inverso (SR 141716A; SR 144528; LY 320135; AM 630).
Questo effetto suggerisce, secondo gli Autori, che il sistema cannabinoide possieda un ‘tono’ che può essere aumentato o diminuito[23].
Considerato che la presenza di pregabalin causa un blocco nella dismissione di glutammato[24,25], p”otrebbe essere la presenza del glutammato stesso a rendere attivi i recettori CB1 e CB2.
Cefalea post-traumatica
L’utilizzo clinico della PEA nella nostra casistica personale, ha dato risultati in molte sindromi neuropatiche, trattate con l’endocannabinoide per inefficacia o sopraggiunta intolleranza al pregabalin:
• FMS e sindromi correlate;
• Vulvodinia;
• Cistite interstiziale;
• Nevralgia ileo-inguinale (post-operatoria);
• Cefalea post-traumatica.
Per quanto riguarda le CRPS, il trattamento con pregabalin e duloxetina è risultato molto efficace e conseguentemente la nostra personale esperienza di terapia con PEA è molto scarsa e non permette valutazioni.
Lo studio della cefalea post-traumatica si è rivelata invece interessante soprattutto per quanto riguarda la terapia.
La cefalea è uno dei disturbi più frequenti dopo un trauma cranico o cervicale.
La classificazione internazionale delle cefalee contempla le cefalee post-traumatiche acute e croniche da trauma (capitolo 5 dell’ICDH-II). Il criterio di classificazione principale è la relazione temporale tra la manifestazione della cefalea ed il trauma. L’intervallo libero, per essere correlato alla cefalea, non deve superare i 7 giorni.
Si parla di cronicizzazione della cefalea se questa persiste per un periodo superiore a tre mesi[26]. Le CPT possono svilupparsi in varie sindromi:
• Tension-type posttraumatic headache ….85%
• Posttraumatic migraine headache ………rara
• Cluster-like headache……………………..6-10%
• Whiplash injury
• Temporomandibular joint syndrome
• Dysautonomic cephalalgia (molto rara, segue ad un trauma della parte anteriore della guaina
carotidea: cefalea severa, unilaterale in regione fronto-temporale, accompagnata da
sudorazione dell’emivolto e midriasi ipsilaterale).
Un infortunio può aggravare temporaneamente una cefalea primaria o scatenarla per la prima volta.
Sono presenti sintomi di accompagnamento:
• Vertigini;
• Ronzio alle orecchie;
• Offuscamento della visione;
• Sintomi psicologici (depressione, ansia, cambiamento di personalità, disturbi del sonno e alterazione della libido, difficoltà di concentrazione, incapacità di lavorare in modo efficiente, difficoltà di mantenere l’attenzione e turbe mnesiche).
La terapia consigliata si avvale di antidepressivi triciclici, beta bloccanti e triptani (nelle forme emicraniche)[26,27].
Interessante notare che le forme croniche sono spesso refrattarie alle terapie e in particolare non rispondono ai farmaci analgesici.
Tutto questo suggerisce una forma di dolore neuropatico, ed infatti la teoria più accreditata per spiegare la causa della sindrome sembra essere il danno assonale diffuso[28].
Abbiamo quindi trattato i casi cronici, refrattari alle consuete terapie, con pregabalin, a volte associato a duloxetina riservando l’associazione con i triptani in una paziente con concomitante emicrania, ottenendo ottimi risultati.
Per quanto riguarda l’uso della PEA, un caso di vulvodinia si è dimostrato esplicativo.
Un quadro franco di vulvodinia venne trattato con pregabalin e duloxetina ottenendo pain relief completo. Come di consueto dopo qualche mese di completo benessere in cui si sarebbe dovuto ottenere desensibilizzazione (evidenziata nelle sindromi neuropatiche dalla permanente scomparsa dell’allodinia), venne sospeso gradualmente il trattamento.
Nelle forme di dolore neuropatico in cui la spina irritativa è ormai spenta, come p. es: CRPS, NPH e DPN, si ottiene la scomparsa della sensibilizzazione in un periodo medio di 8-12 mesi.
Nella vulvodinia, come nella fibromialgia, invece, la causa del dolore non viene risolta ed alla sospensione della terapia, ricompare il dolore.
Il dolore scomparve nuovamente alla somministrazione di pregabalin.
Ad un nuovo tentativo di riduzione del farmaco comparirono vertigini che si attenuavano stranamente ad un aumento del pregabalin.
Lo strano fenomeno venne chiarito dopo qualche mese, quando la paziente in completo benessere senza pregabalin per quanto riguarda la vulvodinia, riportò la ricomparsa di cefalea con vertigini e solo allora riferì un trauma cranico avvenuto 20 anni prima. La cefalea era completamente scomparsa con il pregabalin.
Un ulteriore tentativo di terapia con pregabalin (nel frattempo era ricomparsa anche la vulvodinia) non venne più tollerato dalla paziente per comparsa di effetti collaterali non più conciliabili con l’attività lavorativa.
Venne quindi sostituito il pregabalin con PEA 600 mg bid che portò a completo benessere persistente, senza alcun effetto collaterale.
Conclusioni
Dalla valutazione delle osservazioni cliniche riportate la PEA è efficace quanto il pregabalin nelle sindromi neuropatiche discusse, con il grande vantaggio di non presentare effetti collaterali quali sonnolenza e vertigini, molto importanti nella vita di relazione.
La presenza degli effetti collaterali potrebbe essere spiegata dall’ubiquitarietà dei canali del calcio voltaggio dipendenti nelle terminazioni pre-sinaptiche che vengono bloccati dal pregabalin, mentre la PEA agirebbe solo sui recettori CB2, espressi sulle membrane delle cellule gliali, risparmiando le sinapsi non coinvolte nell’elaborazione del dolore.
Altro grande vantaggio da sottolineare è la sinergia della PEA con i farmaci inibitori dei NMDA; il pregabalin invece perderebbe efficacia nell’associazione, e tale associazione risulta molto utile nelle recrudescenze dolorose di alcune forme di dolore neuropatico, come quelle che si manifestano nella fibromialgia[29].
Fra i farmaci indicati di prima linea ci sono la duloxetina ed il pregabalin; quest’ultimo, se somministrato in associazione alla duloxetina risulta efficace a minore dosaggio e con meno effetti collaterali[3,4].
Anche i farmaci cannabinoidi sono risultati efficaci nella cura del dolore neuropatico, come riportato in una recente rassegna[5].
Mentre conosciamo l’azione della duloxetina sul potenziamento delle vie inibitorie discendenti del dolore, meccanismo ritrovato anche nei cannabinoidi[5,6] e pare anche nel pregabalin[7], non sono note le similitudini o le differenze fra pregabalin e cannabinoidi.
La glia ha un’importante azione sulla genesi del dolore neuropatico, e farmaci particolarmente efficaci sul dolore neuropatico potrebbero avere un’azione di interferenza sulla glia.
Se i cannabinoidi e la PEA (endocannabinoide) hanno similitudini nel meccanismo d’azione del pregabalin, allora potrebbe essere possibile sostituire quest’ultimo farmaco con la PEA, ottenendo l”a scomparsa dei noti effetti collaterali.
Sistema endocannabinoide
Il corpo umano possiede specifici siti di legame per i cannabinoidi sulla superficie di molti tipi cellulari e l’organismo produce diversi endocannabinoidi derivati degli acidi grassi, che si legano ai recettori cannabinoidi (CB), attivandoli. I recettori CB e gli endocannabinoidi costituiscono il sistema cannabinoide endogeno.
Sono stati identificati due tipi di recettore per i cannabinoidi, chiamati CB1 e CB2.
I recettori CB1 si trovano principalmente nell’encefalo, in particolare nei gangli della base, nel globus pallidus e nella substantia nigra e, in misura minore, nel cervelletto, nell’ippocampo, nel nucleo caudato, nel putamen, nell’ipotalamo e nell’amigdala. Sono stati inoltre individuati, ma con minore densità, anche nei polmoni, nel fegato, nei reni e nelle cellule dell’apparato riproduttivo sia maschile che femminile. I recettori CB1 sono invece assenti nel midollo allungato, la parte del sistema nervoso che presiede al controllo delle funzioni respiratorie e cardiovascolari.
Il legame dei cannabinoidi ai recettori CB1 causa una inibizione presinaptica del rilascio di vari neurotrasmettitori (in particolare dopamina e glutammato), ed una stimolazione delle aree della sostanza grigia periacqueduttale (PAG) e del midollo rostrale ventromediale (RVM), che a loro volta inibiscono le vie nervose ascendenti del dolore. A livello del midollo spinale il legame dei cannabinoidi ai recettori CB1 causa una inibizione delle fibre afferenti a livello del corno dorsale.
La stimolazione dei recettori CB1 è responsabile degli effetti euforizzanti dei cannabinoidi, ma anche della loro azione antiemetica, antiossidante, ipotensiva, immunosoppressiva, antinfiammatoria, analgesica, antispastica e stimolante dell’appetito.
Per quanto riguarda i recettori CB2 si è a lungo ritenuto che si trovassero quasi esclusivamente sulle cellule T del sistema immunitario, con la più alta densità a livello della milza; un recente studio ha invece mostrato la loro presenza anche a livello del sistema nervoso centrale[8].” La stimolazione dei recettori CB2 sembra essere responsabile principalmente dell’azione antinfiammatoria e immunomodulatrice dei cannabinoidi.” Ma non è chiarito finora quale dei due recettori o se entrambi siano responsabili dell’azione analgesica esercitata dai cannabinoidi.
Considerata l’efficacia sul dolore neuropatico, è ipotizzabile che l’azione dei cannabinoidi possa essere ricondotta ad un effetto di modulazione della glia operato dai recettori CB2, piuttosto che un’azione analgesica propria, ottenuta dall’attivazione dai recettori CB1.
Se questa ipotesi fosse corretta, si potrebbe ottenere analgesia evitando gli effetti psicotropi evidenziati dai fitocannabinoidi.
Nella fig. 1 sono rappresentati i principali endocannabinoidi, i più importanti fitocannabinoidi e la palmitoiletanolamide (PEA), un endocannabinoide di sintesi.
La PEA è una molecola strutturalmente simile all’endocannabinoide anandamide (AEA) ma, a differenza di quest’ultima, non interagisce con i recettori CB1. La PEA è inoltre in grado di ridurre il rilascio di istamina e di fattori proinfiammatori dai mastociti[9,10].
Plasticità neuronale
La glia è implicata nella percezione ed elaborazione del dolore: attivata dall’infiammazione neurogena, secondaria alla stimolazione nocicettiva, agisce dinamicamente regolando la comunicazione sinaptica neuronale e può incidere sulla via del dolore patologico con il rilascio di neurotrasmettitori, neuromodulatori, citochine proinfiammatorie e chemochine[11]. L’infiammazione, importante meccanismo di difesa, causa anche degenerazione neuronale e sinaptica, ed i residui causati dall’evento lesivo infiammatorio, vengono prontamente eliminati dall’attività macrofagica microgliale per permettere la ricostruzione delle nuove vie sensitive. Questo processo distruttivo/ripartivo è alla base della plasticità neuronale, che in alcuni casi porta alla plasticità maladattativa. La percezione del dolore non si limita a coinvolgere un’analisi momento per momento dell’ingresso nocivo afferente, bensì comporta un processo dinamico che è influenzato dagli effetti delle esperienze passate. Stimoli sensoriali agiscono sui sistemi neurali che sono stati modificati dagli imputs del passato, ed il risultato comportamentale è significativamente influenzato dalla “memoria” di questi eventi precedenti[12,13,14].
Questo fenomeno è anche alla base del concetto di territorio neuroanatomicamente plausibile di Treede[15] in cui la persistenza del dolore causa un’espansione oltre la zona di competenza sensitiva del nervo implicato, come si evidenzia nella sindrome del tunnel carpale o come si può notare in certe coxalgie che presentano un dolore riferito ben oltre il ginocchio, a volte fino alla caviglia, nei pazienti che in passato hanno sperimentato delle lombosciatalgie, od ancora in certi dolori stenocardici che si ripetono sempre nella sede del primo attacco, indipendentemente dal ramo coronarico implicato.
Quando un neurone rilascia glutammato, questo si lega anche ai recettori degli astrociti contigui e si genera un’onda di calcio che si propaga raggiungendo gli astrociti più lontani. L’onda si genera per il formarsi di un gradiente di calcio fra reticolo endoplasmatico e citoplasma, innescato dall’inositolo trifosfato.
La sinapsi elettrica, a differenza della sinapsi chimica, permette la comunicazione tra due cellule eccitabili mediante il passaggio diretto di corrente elettrica. Una caratteristica importante che contraddistingue questo tipo di sinapsi è il verificarsi della trasmissione senza il caratteristico ritardo sinaptico che contraddistingue la trasmissione chimica ed utilizza canali ionici che offrono bassa resistenza alle correnti.
Questi canali vengono definiti gap junctions, e sono morfologicamente formati da particelle intermembranarie costituite da 6 subunità proteiche (connessine) disposte a formare un connessone.
In questo modo il sistema astrocitario, più veloce nella trasmissione dell’informazione, riesce a m”odulare la comunicazione fra neuroni.
Pregabalin e PEA
Il pregabalin risulta efficace nel dolore neuropatico perché blocca la subunità α2δ dei canali del calcio di tipo n[7]. Questi canali, come altri recettori, sono iperespressi nel dolore neuropatico e l’efficacia del farmaco dipende dalla varietà genetica delle subunità coinvolte[16,17,18].
Quando l’impulso nervoso arriva al bottone sinaptico, trasportato dalla differenza di potenziale provocata dallo scambio Na+—K+, vengono attivati i canali del calcio di tipo n che permettono l’ingresso di Ca++ in scambio con K+. E’ il Ca++ intracellulare che causa la degranulazione delle vescicole contenenti i neurotrasmettitori e la conseguente trasmissione sinaptica.
Il pregabalin, inibendo l’ingresso di calcio, impedisce l’uscita dei neurotrasmettitori come il glutammato, la sostanza P ed altri, impedendo l’attivazione degli astrociti[19,20].
Per quanto riguarda i cannabinoidi, l’azione è un po’ diversa: il glutammato rilasciato dal terminale presinaptico si lega ai recettori post-sinaptici ed agli astrociti attivando le interazioni fra astrociti e fra gli astrociti ed i neuroni, mentre la membrana post-sinaptica sintetizza endocannabinoidi che a feed-back inibiscono il rilascio di glutammato bloccando l’attività astrocitaria[24,25].
Mentre molti fitocannabinoidi e gli endocannabinoidi, oltre ad attivare i CB2, possiedono un’azione analgesica diretta, agendo sui recettori CB1 situati sulla membrana presinaptica, la PEA è priva di questo effetto, mentre interagisce con gli astrociti (dotati di recettori CB2) desensibilizzando i circuiti neuronali[8,9,10].
Clinicamente è possibile notarne la differenza: mentre i fitocannabinoidi provocano analgesia appena somministrati, gli effetti della PEA si evidenziano dopo 20-30 giorni dall’inizio del trattamento.
E’ logico pensare che possa esserci un sinergismo fra pregabalin e cannabinoidi.
Nel lavoro dei coniugi Luszczki venirono testate le reazioni dei topi alla piastra calda dopo somministrazione intraperitoneale di pregabalin, WIN 55,212-2 mesylate (cannabinoide sintetico) e pregabalin, dimostrando sinergia nell’associazione farmacologica[21].
In realtà i tests furono eseguiti con dosi molto alte di pregabalin (75 mg/kg) e dosi equivalenti (calcolate sull’effetto antinocicettivo) di cannabinoide, e venne valutata la risposta sul dolore nocicettivo e non su un modello di dolore neuropatico.
Il dubbio che ne deriva è che sia stato misurato non il grado di analgesia, ma il livello di sedazione ottenuto, sicuramente elevato.
Il dubbio sarebbe confermato dalle osservazioni cliniche, dove il pregabalin si comporterebbe come inibitorie dei cannabinoidi sia per quanto riguarda gli effetti mediati dai recettori CB1 che dai CB2.
Un paziente in trattamento con pregabalin 75 mg bid per un dolore neuropatico post-operatorio, cultore occasionare dell’uso ricreativo della cannabis, riferiva assenza totale degli effetti psicotropi dopo aver assunto fitocannabinoidi.
Altri pazienti in trattamento con pregabalin con scarsi risultati per sindrome fibromialgica, venirono ruotati a PEA. In quelli che dimenticarono di sospendere il pregabalin non ci fu miglioramento clinico, cosa invece evidenziata nei pazienti più diligenti. Il miglioramento si evidenziò peraltro alcuni giorni dopo la sospensione del pregabalin.
Ancora, per quanto riguarda le interazioni farmacologiche, il blocco dei recettori NMDA impedisce (in vitro) l’azione del pregabalin sulla degranulazione delle vescicole presinaptiche[22].
Una possibile spiegazione al fenomeno dell’inibizione dell’azione cannabinoide da parte del pregabalin potrebbe essere dedotta dalla presenza di alcuni leganti sintetici che hanno dimostrato un effetto agonista inverso (SR 141716A; SR 144528; LY 320135; AM 630).
Questo effetto suggerisce, secondo gli Autori, che il sistema cannabinoide possieda un ‘tono’ che può essere aumentato o diminuito[23].
Considerato che la presenza di pregabalin causa un blocco nella dismissione di glutammato[24,25], p”otrebbe essere la presenza del glutammato stesso a rendere attivi i recettori CB1 e CB2.
Cefalea post-traumatica
L’utilizzo clinico della PEA nella nostra casistica personale, ha dato risultati in molte sindromi neuropatiche, trattate con l’endocannabinoide per inefficacia o sopraggiunta intolleranza al pregabalin:
• FMS e sindromi correlate;
• Vulvodinia;
• Cistite interstiziale;
• Nevralgia ileo-inguinale (post-operatoria);
• Cefalea post-traumatica.
Per quanto riguarda le CRPS, il trattamento con pregabalin e duloxetina è risultato molto efficace e conseguentemente la nostra personale esperienza di terapia con PEA è molto scarsa e non permette valutazioni.
Lo studio della cefalea post-traumatica si è rivelata invece interessante soprattutto per quanto riguarda la terapia.
La cefalea è uno dei disturbi più frequenti dopo un trauma cranico o cervicale.
La classificazione internazionale delle cefalee contempla le cefalee post-traumatiche acute e croniche da trauma (capitolo 5 dell’ICDH-II). Il criterio di classificazione principale è la relazione temporale tra la manifestazione della cefalea ed il trauma. L’intervallo libero, per essere correlato alla cefalea, non deve superare i 7 giorni.
Si parla di cronicizzazione della cefalea se questa persiste per un periodo superiore a tre mesi[26]. Le CPT possono svilupparsi in varie sindromi:
• Tension-type posttraumatic headache ….85%
• Posttraumatic migraine headache ………rara
• Cluster-like headache……………………..6-10%
• Whiplash injury
• Temporomandibular joint syndrome
• Dysautonomic cephalalgia (molto rara, segue ad un trauma della parte anteriore della guaina
carotidea: cefalea severa, unilaterale in regione fronto-temporale, accompagnata da
sudorazione dell’emivolto e midriasi ipsilaterale).
Un infortunio può aggravare temporaneamente una cefalea primaria o scatenarla per la prima volta.
Sono presenti sintomi di accompagnamento:
• Vertigini;
• Ronzio alle orecchie;
• Offuscamento della visione;
• Sintomi psicologici (depressione, ansia, cambiamento di personalità, disturbi del sonno e alterazione della libido, difficoltà di concentrazione, incapacità di lavorare in modo efficiente, difficoltà di mantenere l’attenzione e turbe mnesiche).
La terapia consigliata si avvale di antidepressivi triciclici, beta bloccanti e triptani (nelle forme emicraniche)[26,27].
Interessante notare che le forme croniche sono spesso refrattarie alle terapie e in particolare non rispondono ai farmaci analgesici.
Tutto questo suggerisce una forma di dolore neuropatico, ed infatti la teoria più accreditata per spiegare la causa della sindrome sembra essere il danno assonale diffuso[28].
Abbiamo quindi trattato i casi cronici, refrattari alle consuete terapie, con pregabalin, a volte associato a duloxetina riservando l’associazione con i triptani in una paziente con concomitante emicrania, ottenendo ottimi risultati.
Per quanto riguarda l’uso della PEA, un caso di vulvodinia si è dimostrato esplicativo.
Un quadro franco di vulvodinia venne trattato con pregabalin e duloxetina ottenendo pain relief completo. Come di consueto dopo qualche mese di completo benessere in cui si sarebbe dovuto ottenere desensibilizzazione (evidenziata nelle sindromi neuropatiche dalla permanente scomparsa dell’allodinia), venne sospeso gradualmente il trattamento.
Nelle forme di dolore neuropatico in cui la spina irritativa è ormai spenta, come p. es: CRPS, NPH e DPN, si ottiene la scomparsa della sensibilizzazione in un periodo medio di 8-12 mesi.
Nella vulvodinia, come nella fibromialgia, invece, la causa del dolore non viene risolta ed alla sospensione della terapia, ricompare il dolore.
Il dolore scomparve nuovamente alla somministrazione di pregabalin.
Ad un nuovo tentativo di riduzione del farmaco comparirono vertigini che si attenuavano stranamente ad un aumento del pregabalin.
Lo strano fenomeno venne chiarito dopo qualche mese, quando la paziente in completo benessere senza pregabalin per quanto riguarda la vulvodinia, riportò la ricomparsa di cefalea con vertigini e solo allora riferì un trauma cranico avvenuto 20 anni prima. La cefalea era completamente scomparsa con il pregabalin.
Un ulteriore tentativo di terapia con pregabalin (nel frattempo era ricomparsa anche la vulvodinia) non venne più tollerato dalla paziente per comparsa di effetti collaterali non più conciliabili con l’attività lavorativa.
Venne quindi sostituito il pregabalin con PEA 600 mg bid che portò a completo benessere persistente, senza alcun effetto collaterale.
Conclusioni
Dalla valutazione delle osservazioni cliniche riportate la PEA è efficace quanto il pregabalin nelle sindromi neuropatiche discusse, con il grande vantaggio di non presentare effetti collaterali quali sonnolenza e vertigini, molto importanti nella vita di relazione.
La presenza degli effetti collaterali potrebbe essere spiegata dall’ubiquitarietà dei canali del calcio voltaggio dipendenti nelle terminazioni pre-sinaptiche che vengono bloccati dal pregabalin, mentre la PEA agirebbe solo sui recettori CB2, espressi sulle membrane delle cellule gliali, risparmiando le sinapsi non coinvolte nell’elaborazione del dolore.
Altro grande vantaggio da sottolineare è la sinergia della PEA con i farmaci inibitori dei NMDA; il pregabalin invece perderebbe efficacia nell’associazione, e tale associazione risulta molto utile nelle recrudescenze dolorose di alcune forme di dolore neuropatico, come quelle che si manifestano nella fibromialgia[29].
 |
| Dott Giorgio Mariot |
n.b.bibiliografia nell'articolo alla fonte
FONTE: https://terapiadolore.wordpress.com/2015/08/26/pea-palmitoiletanolamide-recenti-acquisizioni-in-terapia-del-dolore/