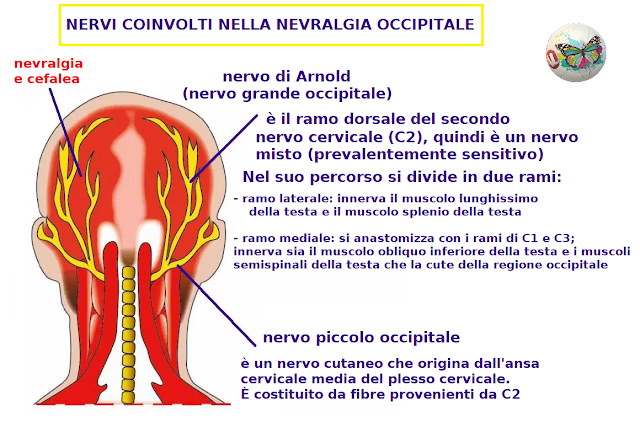Termoregolazione
Meccanismi di termoregolazione
La temperatura corporea dell’uomo è mantenuta in condizioni fisiologiche entro livelli costanti (37 °C±1), mediante un sistema di termoregolazione che conprende diversi meccanismi fra cui i sensori di temperatura centrali e periferici, un centro neuronale regolatorio ed effettori che attraverso reazioni chimico-fisiche sono in grado di variare i livelli della temperatura corporea.
I sensori rilevano le informazioni derivanti dalla periferia corporea (terminazione nervose) e dal sangue, le quali vengono percepite dai neuroni ipotalamici (neuroni W) e da altri tipi di cellule attivando risposta di termodispersione o termoproduzione. La termodispersione avviene principalmente mediante evaporazione (eliminazione di vapore acqueo mediante la respirazione) o la sudorazione, mentre se l’ambiente esterno è freddo, l’ipotalamo attiva una risposta che tende prima a conservare e poi a produrre calore nei tessuti periferici.
L’aumento di temperatura corporea si puo’ distinguere in due processi: ipertermia e febbre che differiscono in quanto nella febbre si ha una alterazione del centro di termoregolazione, mentre nell’ipertermia non si ha attivazione di questo centro. L’ipertermia si verifica in condizioni di lavoro fisico eccessivo o nel colpo di calore favorito da particolari condizioni climatiche (caldo e umidità), farmaci (cocaina, LSD), che rendono difficile la termodispersione, portando in alcune condizioni a temperature corporee anche letali.
La febbre caratteristica nei processi infiammatori è causata da una diminuita termodispersione e dall’attivazione dell’espressione di specifici geni (che sono coinvolti nel processo di neotermogenesi) ed è indotta da fattori pirogeni endogeni (citochine pirogene) e prostaglandine (PG). La diminuita termodispersione (termoconservazione) è attuata mediante vasocostrizione superficiale con vasodilatazione degli organi interni, mentre la neotermogenesi avviene mediante aumento del metabolismo di alcuni tessuti, fenomeni entrambi regolati dall’ipotalamo stimolato dai pirogeni interni (IL-1, IL-6, TNF-a).
PATOGENESI DELLA FEBBRE
I pirogeni attivano la sintesi di PGE2, all’attivazione del nucleo sopraottico e paraventricolare che rilascia peptidi che attivano l’ipofisi ed i centri vasomotori. Ad esempio a livello dell’adenoipofisi si ha il rilascio dell’ormone stimolante le tireotropine (TSH), che agisce a livello tiroideo stimolando la sintesi e rilascio di T3 e T4. Quest’ultimi attivano le ATP-asi ioniche che consumano ATP producendo calore, le termogenine I e II che attivano produzione di calore e la lipolisi e la glicolisi necessari a riprodurre l’ATP.
I pirogeni si possono suddividere in esogeni ed endogeni, i primi sono principalmente le endotossine batteriche in grado di evocare la risposta febbrile, mentre i secondi sono principalmente le citochine pirogene e la PGE2 che direttamente o indirettamente agiscono a livello ipotalamico mediante la stimolazione della sintesi di cAMP, che permette un resettaggio del centro termoregolatore verso un livello di temperatura maggiore. I pirogeni endogeni non sono solo prodotti in presenza di endotossine, virus od altri parassiti, ma anche quando si hanno danni endogeni come necrosi cellulare, infarto, ictus, ecc..
La febbre viene caratterizzata da dei profili termici qualitativi e quantitativi (curva termica) che possono essere di valido aiuto nel diagnosticare la causa dello stato febbrile.
La temperatura corporea dell’uomo è mantenuta in condizioni fisiologiche entro livelli costanti (37 °C±1), mediante un sistema di termoregolazione che conprende diversi meccanismi fra cui i sensori di temperatura centrali e periferici, un centro neuronale regolatorio ed effettori che attraverso reazioni chimico-fisiche sono in grado di variare i livelli della temperatura corporea.
I sensori rilevano le informazioni derivanti dalla periferia corporea (terminazione nervose) e dal sangue, le quali vengono percepite dai neuroni ipotalamici (neuroni W) e da altri tipi di cellule attivando risposta di termodispersione o termoproduzione. La termodispersione avviene principalmente mediante evaporazione (eliminazione di vapore acqueo mediante la respirazione) o la sudorazione, mentre se l’ambiente esterno è freddo, l’ipotalamo attiva una risposta che tende prima a conservare e poi a produrre calore nei tessuti periferici.
L’aumento di temperatura corporea si puo’ distinguere in due processi: ipertermia e febbre che differiscono in quanto nella febbre si ha una alterazione del centro di termoregolazione, mentre nell’ipertermia non si ha attivazione di questo centro. L’ipertermia si verifica in condizioni di lavoro fisico eccessivo o nel colpo di calore favorito da particolari condizioni climatiche (caldo e umidità), farmaci (cocaina, LSD), che rendono difficile la termodispersione, portando in alcune condizioni a temperature corporee anche letali.
La febbre caratteristica nei processi infiammatori è causata da una diminuita termodispersione e dall’attivazione dell’espressione di specifici geni (che sono coinvolti nel processo di neotermogenesi) ed è indotta da fattori pirogeni endogeni (citochine pirogene) e prostaglandine (PG). La diminuita termodispersione (termoconservazione) è attuata mediante vasocostrizione superficiale con vasodilatazione degli organi interni, mentre la neotermogenesi avviene mediante aumento del metabolismo di alcuni tessuti, fenomeni entrambi regolati dall’ipotalamo stimolato dai pirogeni interni (IL-1, IL-6, TNF-a).
PATOGENESI DELLA FEBBRE
I pirogeni attivano la sintesi di PGE2, all’attivazione del nucleo sopraottico e paraventricolare che rilascia peptidi che attivano l’ipofisi ed i centri vasomotori. Ad esempio a livello dell’adenoipofisi si ha il rilascio dell’ormone stimolante le tireotropine (TSH), che agisce a livello tiroideo stimolando la sintesi e rilascio di T3 e T4. Quest’ultimi attivano le ATP-asi ioniche che consumano ATP producendo calore, le termogenine I e II che attivano produzione di calore e la lipolisi e la glicolisi necessari a riprodurre l’ATP.
I pirogeni si possono suddividere in esogeni ed endogeni, i primi sono principalmente le endotossine batteriche in grado di evocare la risposta febbrile, mentre i secondi sono principalmente le citochine pirogene e la PGE2 che direttamente o indirettamente agiscono a livello ipotalamico mediante la stimolazione della sintesi di cAMP, che permette un resettaggio del centro termoregolatore verso un livello di temperatura maggiore. I pirogeni endogeni non sono solo prodotti in presenza di endotossine, virus od altri parassiti, ma anche quando si hanno danni endogeni come necrosi cellulare, infarto, ictus, ecc..
La febbre viene caratterizzata da dei profili termici qualitativi e quantitativi (curva termica) che possono essere di valido aiuto nel diagnosticare la causa dello stato febbrile.
La curva termica si puo’ distinguere in tre fasi:
innalzamento, fastigio e defervescenza. La prima è determinata dal
rialzo termico con caratteristici brividi e contrazioni muscolari, il
fastigio si caratterizza per i valori termici raggiunti (bassi, medi,
alti, altissimi), la durata (ore, giorni, anni) e per come vengono
mantenuti (continui o discontinui). La defervescenza indica la scomparsa
della febbre e puo’ essere rapida (per crisi) o lenta (per lisi).
Fase del rialzo termico: sensazione di freddo, brividi,
pallore cutaneo con conseguente vasocostrizione (riduzione della
termodispersione). Fase del fastigio: quando i
centri termoregolatori si posiziona a temperature maggiori di 37 °C,
scompare la sensazione di freddo e compare quella di calore. Si attiva
con l’aumento di PGE2 e si mantiene per tutto il periodo in cui si ha
produzione di PGE2 in eccesso. Fase di
defervescenza: sensazione di caldo ed abbassamento della temperatura,
con riduzione delle citochine infiammatorie e di conseguenza di PGE2.
I
centri termoregolatori riportano lentamente (per crisi) o velocemente
(per lisi) il corpo a livelli di temperatura normale attivando la
sudorazione per facilitare l’abbassamento della temperatura. Nabissi 14 57
Per quanto riguarda il trattamento dello stato febbrile si
utilizzano, quando necessario, antipiretici che agiscono inibendo le
cicloossigenasi (COX) che sono responsabili della produzione di PGE2
come l’aspirina o altri farmaci non steroidei, oppure farmaci steroidei
(glucocorticoidi) che inibiscono la fosfolipasi A2 responsabile del
rilascio di acido arachidonico necessario per la sintesi di PGE2.