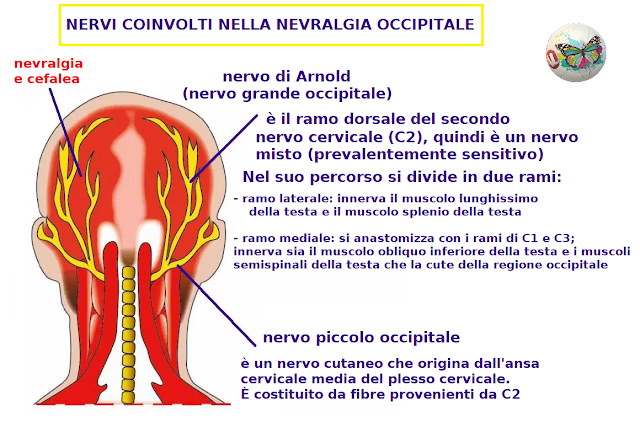I deficit di attenzione e concentrazione nella Fibromialgia e nella Sindrome Immuno-Neurotossica Ambientale (MCS): il d2-R come strumento di diagnosi
Questo studio è il secondo in cui presento i risultati ottenuti sui Soggetti citati, il primo analogo è comparso su QI di novembre 2017, al quale rimando per l’introduzione ed una sintetica descrizione delle sindromi in esame.
Nel lavoro di allora i casi oggetto di esame comparato erano 11 in totale; in quello attuale, i soggetti salgono a 28 (sono compresi anche gli 11 precedenti). Pertanto, il significato diagnostico subisce un ulteriore incremento, come andremo ad osservare.
Il mio interesse professionale e scientifico in queste patologie è dettato principalmente da un impiego pratico, ovvero per evidenziare tali deficit al fine di presentarli – accanto alle sindromi citate –, alle visite nelle varie commissioni d’invalidità per aumentare il punteggio complessivo. Infatti, la continua inabilità che tali sindromi comportano, ha risvolti importantissimi sia sul piano dell’adattamento, sia sul piano neurocognitivo, colpendo le capacità di memoria, attenzione e concentrazione, fino ad arrivare anche ad un abbassamento nelle funzioni esecutive, ovvero – sempre in termini ristretti – la capacità di affrontare problemi, mettere in atto strategie risolutive, apprendere dagli errori. Non ci si tragga in inganno: tali “funzioni” governano pressoché tutti gli aspetti della vita quotidiana e il loro non adeguato svolgimento è fonte di grandi e gravi ostacoli nell’esistenza di tutti i giorni. Non ci si accorge della loro importanza fino a che non decadono.
Nel lavoro di allora i casi oggetto di esame comparato erano 11 in totale; in quello attuale, i soggetti salgono a 28 (sono compresi anche gli 11 precedenti). Pertanto, il significato diagnostico subisce un ulteriore incremento, come andremo ad osservare.
Il mio interesse professionale e scientifico in queste patologie è dettato principalmente da un impiego pratico, ovvero per evidenziare tali deficit al fine di presentarli – accanto alle sindromi citate –, alle visite nelle varie commissioni d’invalidità per aumentare il punteggio complessivo. Infatti, la continua inabilità che tali sindromi comportano, ha risvolti importantissimi sia sul piano dell’adattamento, sia sul piano neurocognitivo, colpendo le capacità di memoria, attenzione e concentrazione, fino ad arrivare anche ad un abbassamento nelle funzioni esecutive, ovvero – sempre in termini ristretti – la capacità di affrontare problemi, mettere in atto strategie risolutive, apprendere dagli errori. Non ci si tragga in inganno: tali “funzioni” governano pressoché tutti gli aspetti della vita quotidiana e il loro non adeguato svolgimento è fonte di grandi e gravi ostacoli nell’esistenza di tutti i giorni. Non ci si accorge della loro importanza fino a che non decadono.
Il d2-R e la misurazione delle capacità attentive
Riporto di seguito l’introduzione al d2-R estratta dal precedente articolo citato:
Accanto ad altri test
neuropsicologici specifici per altre funzioni, ho inserito da un paio di
anni il d2-R, il test di attenzione concentrata, che risulta connotarsi
come la prova in tale ambito più utilizzata negli USA e in Europa. Fino
al marzo di quest’anno (2017), impiegavo la versione cartacea del test:
all’esaminato viene chiesto di riconoscere stimoli target in mezzo ad
elementi di disturbo, attraverso la loro evidenziazione in un tempo
prefissato con una prova “carta e matita”. Già in questa versione,
notavo caratteristiche comuni nei soggetti di cui sopra: tutti
mostravano importanti e significative perdite nella capacità in esame.Con
l’avvento della versione informatizzata del test, che prevede norme
europee per soggetti tra i 18 ed i 55 anni di ambo i sessi, non solo la
procedura di somministrazione è ancora più standardizzata, ma è più
facile confrontare i risultati a fini di valutazione e di studio. Vi
presento quanto da me ottenuto mediante questa prova, che non esito a
definire come altamente significativa e pragmatica, qualità,
quest’ultima, purtroppo non sempre presente nel panorama testistico.A
tutti i soggetti è stato somministrato il d2-R nel medesimo ambiente
“bonificato”, ovvero privo di stimoli di disturbo olfattivo e uditivo,
nelle prime ore pomeridiane di giorni diversi. A tutti i soggetti sono
state diagnosticate – attraverso una molteplicità di esami ed indagini
cliniche specifiche indispensabili, svolte nell’arco di alcuni anni –,
le patologie citate e, quindi, non abbiamo presenti “casi dubbi”. La
certificazione è sempre a cura delle ASL di competenza e di specialisti
medici accreditati, ottenuta attraverso un meticoloso studio
strumentale, di prove genetiche, epigenetiche e polimorfismi per l’MCS,
anche per le indubbie difficoltà di inquadramento che dette malattie
ancora comportano, come accennato. Con la precedente versione cartacea
del test ho esaminato un numero ben superiore di soggetti analoghi a
quelli presentati in questa sede, ottenendo gli stessi risultati; ma
tale versione non consente quella presentazione dei risultati che è resa
possibile dalla recente informatizzazione.Il test, in
quest’ultima elaborazione, prevede la diretta interazione dell’esaminato
con il computer per la sua esecuzione; egli viene guidato attraverso un
congruo periodo di familiarizzazione prima dell’esecuzione vera e
propria, che consiste nel riconoscere lo stimolo target accanto ad altri
stimoli di “disturbo”. Una volta terminato il compito, si ottengono
subito i risultati mediante un report che analizza i dettagli della
prestazione. Il test evidenzia:
- Performance di concentrazione – PC (ovvero la complessiva capacità di attenzione e concentrazione, il fulcro della prova); bassi punteggi fanno propendere per una capacità di concentrazione deficitaria
- Risposte esatte – RE: numero di stimoli elaborato; bassi punteggi significano ritmi di lavoro bassi
- Percentuale di errori – RE% (percentuale di errori sul totale delle risposte corrette: evidenzia lo “stile di lavoro” del soggetto, ovvero la sua velocità in rapporto all’accuratezza ottenuta (un alto punteggio significa una maggiore “prudenza” esecutiva e quindi una migliore accuratezza; un basso punteggio significa una bassa accuratezza).
Dunque, alla luce di queste norme, un
qualunque risultato di “basso” livello conseguito in una delle tre aree
esplorate, ha come significato la caduta – di diversa gravità a seconda
dei punteggi realizzati e delle aree interessate-nelle capacità di
attenzione e concentrazione.
In Figura 1a, b, c vengono presentati i risultati della variabile PC
realizzati da 28 donne affette dalle patologie citate (non ci sono
differenze tra MCS e Fibromialgici), mediante sovrapposizione dei
valori. Questi risultati e tutti gli altri sono presentati in tre figure
distinte, poiché il test non consente sovrapposizioni per più di 10
casi per volta. Quindi, 2 tabelle per 10 soggetti e una per 8 soggetti.
Per tutte le pazienti, si ottengono indicazioni chiare delle difficoltà
di attenzione concentrata esperite. Ho volutamente inserito in questa
disamina anche i 3 soggetti che escono dall’intervallo di età
considerato dalla prova (età superiore ai 55 anni), poiché, come avevo
già osservato precedentemente, le loro cadute prestazionali sono tali da
non lasciare dubbi sul significato diagnostico, confortati anche dalle
norme del d2-R, che consentono tali inferenze. Infatti, anche ascrivendo
loro dovutamente una performance un po’ più elevata (ricordando
comunque che non superano in maniera eccessiva l’intervallo superiore di
età), come espresso poco fa i soggetti mostrano un evidente calo
nell’esecuzione.
Per 24 dei soggetti esaminati, la caduta è univoca e di importante livello; per 4 pazienti (JB, IR, VI, SPA), si osserva un andamento migliore in questa parte.
Per 24 dei soggetti esaminati, la caduta è univoca e di importante livello; per 4 pazienti (JB, IR, VI, SPA), si osserva un andamento migliore in questa parte.



Figura 1a, b, c – PC Performance di concentrazione (N=28)
In Figura 2a, b, c viene presentato l’andamento dei punteggi della variabile RE,
una misura della velocità di elaborazione che prescinde dalla
correttezza delle risposte. Di nuovo, la caduta è univoca in tutti i
soggetti, tranne che per SPA. Per la maggior parte di essi (18 casi su
28), abbiamo T < 35, che significa prestazioni “molto basse”, quindi
particolarmente deficitarie.



Figura 2a, b, c – RE Risposte esatte (N=28)
I grafici di Figura 3a, b, c evidenziano l’accuratezza di elaborazione del test da parte degli esaminati (RE%). Punteggi
alti indicano un numero di errori inferiore alla media. Tale valore
assume nei casi presentati – in rapporto agli altri risultati –, la
ricerca di una sorta di “compensazione” in accuratezza che provi a
bilanciare le difficoltà in altri versi esperite. In altri termini, “ho difficoltà a concentrarmi e quindi vado molto più lentamente per cercare di commettere meno errori possibile”. Comportamento che ricerca un adattamento, ma purtroppo il danno di fondo rimane importante.



Figura 3a, b, c – ER% Percentuale di errori (N=28)
Nella conclusiva (Tabella 4a, b, c) sono
presentati tutti i valori per tutte e tre le aree in contemporanea.
Questo consente una ancor più rapida visuale della qualità delle
prestazioni e l’individuazione dei deficit.



Tabella 4a, b, c – Grafici riassuntivi (N=28)
Conclusioni
Attraverso questi risultati comparati –
ottenuti su un sempre più alto numero di persone colpite da Fibromialgia
ed MCS –, abbiamo evidenziato come i deficit di attenzione e
concentrazione costituiscano un aspetto patologico delle malattie
“ambientali”, tanto importante da costituire parte di uno dei tre
criteri mediante i quali attestare la diagnosi di Fibromialgia, come
espresso dalle recenti “Linee di indirizzo regionali per la diagnosi ed il trattamento della Fibromialgia”, pubblicate in data 5 Febbraio 2018 a cura della Regione Emilia Romagna.
Tutti i soggetti esaminati presentano deficit in questa funzione cognitiva e la quasi totalità di essi mostra imponenti abbassamenti qualitativi e quantitativi.
Il d2-R si è rivelato uno strumento determinante per la misurazione di questi deficit: quando si richiede una attenzione elevata nell’esecuzione di un compito (come nella prova con il d2-R), il paziente incorre in break-down che non gli consentono di portarlo a termine o di eseguirlo in maniera corretta. Tali cadute prestazionali si manifestano e sono più frequenti e dirompenti in situazioni della vita quotidiana, a causa della presenza di stimoli di disturbo che si prolungano inevitabilmente nel tempo, che costituiscono per questa tipologia di soggetti un ostacolo spesso di difficile superamento.
La progressione di questi risultati da me ottenuti con il d2-R è in atto dal marzo dell’anno scorso e voglio ancora ricordare che mancano all’appello tutti i soggetti da me precedentemente esaminati con la forma cartacea del test, che hanno realizzato gli stessi valori indicativi di deficit, ma non presentabili nei dettagli di questa versione computerizzata, dunque non comparabili alla stessa maniera.
Il clinico ha a disposizione anche altre prove neuropsicologiche standardizzate per la misurazione di queste difficoltà; ma il d2-R possiede caratteristiche di grande pragmaticità e riunisce in sé qualità e precisione che difficilmente si trovano in altri test analoghi.
Tutti i soggetti esaminati presentano deficit in questa funzione cognitiva e la quasi totalità di essi mostra imponenti abbassamenti qualitativi e quantitativi.
Il d2-R si è rivelato uno strumento determinante per la misurazione di questi deficit: quando si richiede una attenzione elevata nell’esecuzione di un compito (come nella prova con il d2-R), il paziente incorre in break-down che non gli consentono di portarlo a termine o di eseguirlo in maniera corretta. Tali cadute prestazionali si manifestano e sono più frequenti e dirompenti in situazioni della vita quotidiana, a causa della presenza di stimoli di disturbo che si prolungano inevitabilmente nel tempo, che costituiscono per questa tipologia di soggetti un ostacolo spesso di difficile superamento.
La progressione di questi risultati da me ottenuti con il d2-R è in atto dal marzo dell’anno scorso e voglio ancora ricordare che mancano all’appello tutti i soggetti da me precedentemente esaminati con la forma cartacea del test, che hanno realizzato gli stessi valori indicativi di deficit, ma non presentabili nei dettagli di questa versione computerizzata, dunque non comparabili alla stessa maniera.
Il clinico ha a disposizione anche altre prove neuropsicologiche standardizzate per la misurazione di queste difficoltà; ma il d2-R possiede caratteristiche di grande pragmaticità e riunisce in sé qualità e precisione che difficilmente si trovano in altri test analoghi.