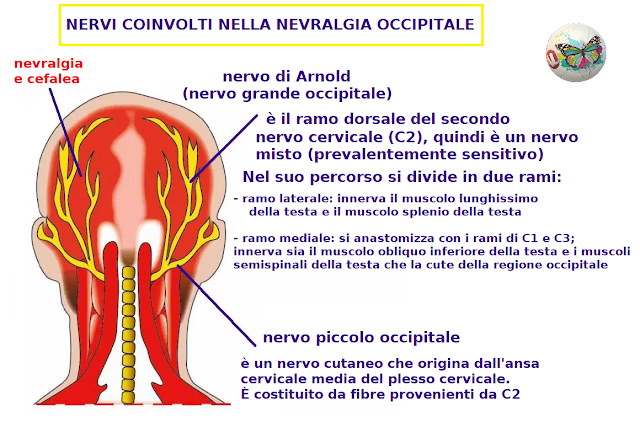SINDROME ALGODISTROFICA
La sindrome algodistrofica viene definita come una patologia caratterizzata da un’intensa sintomatologia algica, accompagnata da una serie di manifestazioni locali quali l’edema, le alterazioni vasomotorie e sudomotorie, la rigidità articolare e l’osteoporosi con una possibile evoluzione verso manifestazioni distrofiche e atrofiche.
La sindrome algodistrofica viene spesso sottodiagnosticata, malgrado abbia una incidenza discretamente elevata, e risulta, ad oggi, ancora tra le malattie rare. Tuttavia esami come la risonanza magnetica e la scintigrafia consentono un’indagine precoce e l’individuazione delle specifiche alterazioni di questa patologia. Uno studio epidemiologico sul dato di incidenza della CRPS (complex regional pain syndrome type 1), elaborato dall’Erasmus Medical Center, Pharmaco-epidemiology Unit, Departments of Medical Informatics and Epidemiology and Biostatistics, e dall’ Erasmus Medical Center, Department of Anesthesiology, dei Paesi Bassi ne evidenzia l’impatto sociale per il rapporto di 26.2 per 100,000 persone all’anno. Secondo questo studio le donne, di età compresa tra i 61 e i 70 anni, ne sono affette tre volte di più rispetto agli uomini. “Lo schema terapeutico sperimentato nello studio che abbiamo portato avanti”, dice il prof. Massimo Varenna,”prevede 4 somministrazioni (2 volte per 2 settimane), diluite in soluzione fisiologica ed iniettate per via venosa, ed ha dato come risultati la netta riduzione sia della sintomatologia dolorosa, che dei segni locali di infiammazione, fino alla remissione completa della disabilità a livello della sede di malattia”.
“In base a queste evidenze medico-scientifiche,”conclude il Professor Massimo Varenna,” risultano
chiari due elementi palesemente interconnessi tra loro: da un lato
l’importanza di sensibilizzare soprattutto i reumatologi e altri
specialisti sull’algodistrofia in modo che siano in grado di
diagnosticare i pazienti entro un tempo il più breve possibile
dall’insorgenza della patologia. Dall’altro la necessità di tenere in
considerazione la nuova indicazione di AIFA, perché, oltre ad una
diagnosi precoce, venga adottato, da oggi in poi, l’unico schema
terapeutico validato, quello con neridronato. Quest’approccio potrebbe
infatti evitare guai a pazienti, frequentemente costretti a vere e
proprie peregrinazioni per essere curati con terapie non validate e
spesso particolarmente costose per il SSN.”
fonte http://www.24orenews.it/salute-a-benessere/salute/11183-algodistrofia-trovato-il-primo-farmaco-al-mondo
L’ algodistrofia o sindrome algodistrofica (SA) o più correttamente la sindrome dolorosa regionale complessa si caratterizza da manifestazioni cliniche sproporzionate rispetto alla noxa patogena.
L’evento scatenante della algodistrofia è nel 50-75% dei casi un
trauma, di qualsiasi entità o natura, dall’immobilizzazione conseguente
e, in misura minore, secondaria a patologie ischemiche cerebrali o
cardiache, a neoplasie e in rari casi ad alcune malattie infettive. Non è
infrequente comunque osservare casi spontanei di SA/CRPS-1 senza che
sia possibile ricondurla ad un evento scatenante nella sede colpita. Le
regione più colpite sono la mano e la spalla nell’arto superiore e il
piede e ginocchio nell’arto inferiore.
Il dolore, considerato il sintomo cardine di questa malattia, fa parte di uno vasto spettro di manifestazioni cliniche che possono essere raggruppate in 3 gruppi principali:
Il dolore, considerato il sintomo cardine di questa malattia, fa parte di uno vasto spettro di manifestazioni cliniche che possono essere raggruppate in 3 gruppi principali:
- Alterata sensibilità: iperalgesia e allodinia
- Alterazioni vasomotorie e sudomotorie: edema, asimmetria di colorito e temperatura o sudorazione
- Alterazioni motorie e trofiche: osteopenia o osteoporosi localizzata, limitazione dei ROM* articolari, ipotonia e ipotrofia muscolare, tremori e distonie, alterazione degli annessi cutanei (unghie e peli)
I criteri classificativi e diagnostici per l’ algodistrofia proposti
dalla IASP (International Association for the Study of Pain), sono molto
sensibili, quindi raramente viene mancata una diagnosi, ma poco
specifici con conseguente rischio di sovra diagnosi. Per tale motivo
sono state pubblicate delle modifiche che, grazie ad un aumento della
specificità e riduzione della sensibilità, hanno ottenuto una maggiore
precisione diagnostica, a scapito però di una percentuale di pazienti
che non rientra più nei criteri di CRPS tipo 1 (algodistrofia), né CRPS
tipo 2 (causalgia – da lesione nervosa) e per cui è stato proposto un
terzo tipo (CRPS tipo 3 – not otherwise specified). A tutt’oggi però non
esistono dei criteri universalmente accettati.
La difficoltà di classificare l’ algodistrofia e la presenza di manifestazioni cliniche del tutto aspecifiche che si possono presentare in quadri clinici eterogenei, possono facilmente indurre ad un errore o ad un ritardo diagnostico.
La difficoltà di classificare l’ algodistrofia e la presenza di manifestazioni cliniche del tutto aspecifiche che si possono presentare in quadri clinici eterogenei, possono facilmente indurre ad un errore o ad un ritardo diagnostico.
[* La flessibilità articolare è definita dal ROM (Range Of Motion),
ossia dai gradi di libertà permessi da una specifica articolazione. ]
Meccanismi patogenetici.
Nonostante il recente fervore scientifico, tuttavia le cause non sono
state del tutto chiarite, ma si sta facendo sempre più consistente
l’ipotesi che questa sindrome sia il risultato dell’interazione di più
meccanismi patogenetici, che danno ragione della variabilità di
manifestazioni cliniche tipica di questa malattia:
- Flogosi neurogena sostenuta da neuropeptidi e citochine proinfiammatorie
- Disfunzione del sistema nervoso simpatico e sensitivizzazione centrale con cronicizzazione del dolore e alterata percezione del dolore
- Danno e/o disfunzione del microcircolo che causa ipossia locale
- Acidosi conseguente all’ipossia potrebbe essere correlata all’osteoporosi localizzata per meccanismo extra osteoclastico, causando l’idrolisi delle idrossiapatiti rendendo ragione della rapidità di onset.
- Disuso di protezione che può causare sindrome neurologica tipo neglect
- Processo di guarigione aberrante
Diagnosi e strumenti diagnostici.
Il rischio di sovra diagnosi è sempre da tenere in considerazione.
Una anamnesi dettagliata e un attento esame obiettivo sono il principale
strumento a nostra disposizione per formulare il dubbio diagnostico di
algodistrofia. A questo scopo i criteri IASP sono un valido supporto che
chiunque si occupi di questa patologia dovrebbe tenere presente. Solo
dopo aver formulato il dubbio diagnostico possono essere eseguiti le
indagini laboratoristiche e strumentali necessarie a confermare la
diagnosi o a escludere le patologie che rientrano nella diagnostica
differenziale.
Non esistono test specifici in grado di confermare la diagnosi di
algodistrofia o CRPS-1. Tuttavia, la diagnosi differenziale include
altre forme di neuropatie oltre ad una serie di malattie metaboliche e
sistemiche, vascolari e reumatologiche. Inoltre entrano in diagnostica
differenziali anche patologie gravi e neoplasie per cui, nonostante il
quadro clinico possa essere classico, è comunque indicato richiedere gli
accertamenti.
- Esami di laboratorio: emocromo, VES, proteina C reattiva, anticorpi antinucleo, fattore reumatoide, complementemia, protidogramma e immunoelettroforesi, metabolismo osseo e assetto metabolico.
- EMG/ENG: fondamentale per valutare la neuroanatomia/fisiologia che sottende i sintomi
- RX: nelle fasi più avanzate permette la visualizzazione della demineralizzazione ossea e di eventuali fratture o cedimenti ossei.
- Scintigrafia ossea trifasica: presenta il vantaggio rispetto alla RX di risultare positiva anche in fasi precoci di malattia.
- RM: in grado di valutare sia le strutture articolari, l’edema osseo e i tessuti molli. E’ molto sensibile in fase precoce ma poco specifica.
- Ecocolordoppler vascolare: da tenere in considerazione per la diagnostica differenziale
- QST (quantitative sensory test): utile per discriminare la soggettività del paziente nel testare iperalgesia e allodinia. Test ripetibile e di basso costo che può essere usato anche come monitoraggio della risposta alla terapia.
- AFT (autonomic function tests): quali la flussimetria laser doppler o la misurazione infrarossa della temperatura. Come per il QST possono essere usati per il monitoraggio.
- Raramente risulta necessario eseguire le biopsie cutanee, muscolari o dei nervi periferici, che devono essere riservate solo a casi ben specifici.
Terapia.
A causa della mancanza di criteri classificativi univoci e delle
ancora scarse conoscenze dei meccanismi fisiopatologici che sottendono
questa malattia, gli studi scientifici in grado di dimostrare
l’efficacia di una terapia sono difficili e i dati derivanti sono spesso
non confrontabili, per cui esistono pochi dati di terapia basati
sull’evidenza.
- Corticosteroidi. La loro efficacia è stata dimostrata specie nelle fasi precoci di malattia, quando la flogosi è evidente. Le recenti scoperte sui meccanismi di mantenimento della flogosi neurogena hanno ridato importanza a questi farmaci.
- Bisfosfonati. Nonostante il meccanismo di azione non sia completamente noto, l’efficacia dei bisfosfonati è stata dimostrata in diversi studi, in particolare, neridronato ha ottenuto l’indicazione da parte dell’agenzia del farmaco per la SA/CRPS-1 in fase acuta precoce.
- Calcitonina. La somministrazione di calcitonina per via intranasale è risultata efficace nella ridurre il dolore
- Oppioidi. Gli oppioidi sono gli analgesici di scelta per il dolore della SA/CRPS-1 ma devono essere parte integrante di una terapia del dolore combinata.
- FANS. Non esistono dati di letteratura certi, ma possono essere indicati nel dolore lieve moderato o coadiuvare la terapia con analgesici, specie in caso di episodi di breakthrough pain
- TCA, SSRI e SNRI. Gli antidepressivi triciclici, gli inibitori selettivi del reuptake della serotonina e quelli della serotonina noradrenalina sono farmaci che trovano indicazione nel dolore neuropatico per cui possono essere usati in combinazione con altri analgesici.
- Bloccanti del canale del sodio. La lidocaina si è dimostrata efficace nelle formulazioni sia endovenose che transdermiche nel ridurre il dolore nella sede di applicazione. Può trovare applicazione anche durante la riabilitazione per permettere l’intervento riabilitativo stesso quando il dolore ne impedirebbe lo svolgimento.
- GABA agonisti. Il baclofen trova indicazione sia nel trattamento delle spasticità che delle neuropatie.
Altre opzioni farmacologiche che hanno trovato indicazione nel
trattamento della SA/CRPS-1 sono le infusioni di ketamina, fentolamina,
betabloccanti, clonidina e immunoglobuline endovena.
Segnaliamo infine che le tra le opzioni terapeutiche sono state riportate, con risultati alterni, il blocco del simpatico, la simpaticectomia e la neurostimolazione midollare.
Segnaliamo infine che le tra le opzioni terapeutiche sono state riportate, con risultati alterni, il blocco del simpatico, la simpaticectomia e la neurostimolazione midollare.
Il trattamento riabilitativo è un aspetto fondamentale del
programma terapeutico e deve essere iniziato il più precocemente
possibile. Il protocollo riabilitativo deve essere ritagliato sul
paziente e sulla fase di malattia, adattandolo tempestivamente
all’esigenza, alla tollerabilità e al variare delle manifestazioni
cliniche.
Pertanto, risulta fondamentale la stretta collaborazione tra medico e
fisioterapista per la formulazione della corretta strategia terapeutica
e riabilitativa. I trattamenti devono essere complementari e
sequenziali per ottenere il maggior beneficio possibile, accompagnando
il paziente durante tutto il decorso di malattia.
FONTE http://www.felicegalluccio.it/sindromi-algodistrofiche-sindrome-dolorosa-regionale-complessa/
ATTI - XVIII CONGRESSO NAZIONALE SIOMMMS 2018
La diagnosi è posta sulla base di criteri clinici, come codificato dall’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP). Seppur in assenza di riscontri di laboratorio o metodiche strumentali dotate di adeguati livelli di sensibilità e specificità, la Risonanza Magnetica (RMN) è spesso impiegata in fase diagnostica poiché in grado di documentare un alterato segnale associato alla presenza di edema osseo (BME) nelle fasi iniziali di malattia.
Tuttavia la presenza di BME non è patognomonica di algodistrofia, infatti, con la progressiva diffusione dell’impiego
della RMN nella diagnostica delle patologie dell’apparato locomotore, è stato possibile riscontrare tale rilievo in un elevato numero di patologie, le quali, con differenti meccanismi patogenetici, determinano un’alterazione della normale istologia midollare in grado di generare le medesime alterazioni di segnale quando indagate con la RMN.
La presentazione di differenti quadri clinici diversi dalla Sindrome Algodistrofica ed erroneamente diagnosticati come tale ha lo scopo di illustrare come un medesimo segnale di BME alla RMN non abbia nessun valore diagnostico in senso algodistrofico, se non correlato al dato clinico e anamnestico che rappresenta il requisito fondamentale per un corretto inquadramento di tale patologia.
Tuttavia la presenza di BME non è patognomonica di algodistrofia, infatti, con la progressiva diffusione dell’impiego
della RMN nella diagnostica delle patologie dell’apparato locomotore, è stato possibile riscontrare tale rilievo in un elevato numero di patologie, le quali, con differenti meccanismi patogenetici, determinano un’alterazione della normale istologia midollare in grado di generare le medesime alterazioni di segnale quando indagate con la RMN.
La presentazione di differenti quadri clinici diversi dalla Sindrome Algodistrofica ed erroneamente diagnosticati come tale ha lo scopo di illustrare come un medesimo segnale di BME alla RMN non abbia nessun valore diagnostico in senso algodistrofico, se non correlato al dato clinico e anamnestico che rappresenta il requisito fondamentale per un corretto inquadramento di tale patologia.
Focus su “la sindrome algodistrofica”
ATTI - XVI CONGRESSO NAZIONALE SIOMMMS 2016
Le conoscenze circa i meccanismi patogenetici della sindrome
algodistrofica (SA) hanno conosciuto negli ultimi decenni un notevole
progresso legato in primo luogo all’affinarsi di metodiche biochimiche
che hanno individuato sia localmente che a livello sistemico una serie
di neuromediatori e di citochine coinvolti nella genesi e nel
mantenimento del processo di “neuroflogosi”, in grado di innescare la
malattia e connessi alle manifestazioni cliniche tipiche delle fasi
precoci (edema, eritrosi, aumento del termotatto). Nelle fasi
successive, il disturbo del microcircolo e il danno microvascolare
rendono conto dell’evoluzione clinica verso la fase definita “fredda”.
Sono stati inoltre messi a punto modelli animali che consentono di
ottenere quadri clinici sovrapponibili alla SA nell’uomo e quindi
indagabili estensivamente nelle diverse fasi che la malattia presenta.
Anche per ciò che concerne l’approccio terapeutico ottimale negli ultimi
tempi sono state superate molte delle incertezze derivanti dagli studi
compiuti in passato dove la variabilità della durata e della gravità di
malattia, l’eterogeneità delle casistiche e dei parametri clinici
indagati costituivano le problematiche alla base del dato che non
esisteva un’assoluta identità di opinioni circa il trattamento ottimale
della SA.
La classe farmacologica che a tutt’oggi offre le maggiori garanzie di
efficacia è rappresentata dai Bisfosfonati. Il loro razionale d’impiego
ha fatto inizialmente riferimento all’efficacia analgesica nel
trattamento di alcune patologie scheletriche e, più recentemente, alla
dimostrazione che tali farmaci, una volta raggiunte localmente elevate
concentrazioni, interferiscono con le dinamiche patogenetiche alla base
della neuroflogosi. Clodronato, Pamidronato e Alendronato, somministrati
a dosaggi elevati, sembrano tutti possedere un considerevole profilo
d’efficacia, con riscontri provenienti da studi randomizzati in doppio
cieco.
Recentemente anche per il Neridronato sono state ottenute
dimostrazioni di efficacia analoghe e per molti aspetti superiori
rispetto agli altri Bisfosfonati.
Recenti indagini dimostrano che la
terapia con Bisfosfonati sembra possedere maggiori probabilità di
successo quanto più precocemente venga instaurata, in presenza di
evidenti manifestazioni flogistiche e in forme che presentano quale
evento scatenante un chiaro coinvolgimento scheletrico.